IL POETA DELL’INFINITO
Nella provincia di Macerata, nelle Marche, sulla cima quasi pianeggiante di un colle, sorge un comune chiamato Recanati, diventato famoso, in particolare, per essere stato la città natale di un celebre poeta e letterato dell’‘800, che tutti i ragazzi italiani hanno incontrato sui libri di scuola fin dalle elementari: Giacomo Leopardi. Quando ero piccola, trovandomi quindi a leggere alcune sue poesie a scuola, avevo ricevuto l’impressione che, al loro interno, egli esprimesse un’idea così tanto malinconica, riguardo alle cose della vita, ad un punto tale che a me pareva di non riuscire a sostenerla, dentro di me, e tentavo quindi di respingerla con tutte le mie energie mentali! Ma crescendo, durante le superiori mi sono poi ricreduta, tanto da scegliere di portare il suo pensiero e la sua poetica come materia all’esame di maturità…
Egli nacque, dunque, nel 1798, in questo piccolo centro marchigiano -all’epoca facente parte dello Stato Pontificio-, che è una tipica “città-balcone”, in quanto da essa si può scorgere un vasto e bellissimo panorama su valli, colline e borgate circostanti. I suoi genitori, provenienti entrambi da una famiglia di nobili natali, furono molto severi, spesso decisamente rigidi, con i figli -ben dieci, dei quali Giacomo era il primo; tuttavia, purtroppo, soltanto cinque di loro, compreso lui, raggiunsero l’età adulta. Nonostante ciò, la sua infanzia trascorse piuttosto felice: egli giocava molto e allegramente con i suoi fratelli, in particolare con i due più vicini di età, Carlo e Paolina; a volte era un po’ prepotente, e altre gridava gioioso correndo in giardino… Ma presto le cose cambiarono: la madre, Adelaide degli Antici, era una persona fredda e distante, incapace di dimostrare l’affetto di cui lui avrebbe avuto bisogno, e per di più era molto legata alle convenzioni sociali, nonché religiosa fino alla superstizione; mente il padre, il conte Monaldo Leopardi, aveva idee reazionarie ed era interamente dedito agli studi, tanto da non accorgersi del disagio che cominciava a farsi largo nell’animo del figlio. Il quale, inoltre, dall’adolescenza cominciò a manifestare i segni di una malattia fisica altamente invalidante, che il neurochirurgo dott. Erik P. Sganzerla dell’Ospedale San Gerardo-Università Bicocca, appassionato studioso di Leopardi, ha identificato come una Spondilite Anchilosante giovanile: tale malattia colpisce in particolare la colonna vertebrale, causando rigidità e deformazione di questa, nonché dolori, gracilità di costituzione e tutta una serie di altri problemi di salute correlati: il giovane Leopardi aveva insomma di che soffrire, proprio all’inizio della sua esistenza; è sbagliato però credere che sia stata unicamente la sua sofferenza personale a spingerlo ad elaborare una filosofia di vita così pessimistica, come ci è piuttosto noto dai ricordi di scuola… Fin da bambino egli dimostrò un’intelligenza vivace ed un profondo interesse per la cultura, che lo portarono a gettarsi a capofitto nello studio -che in seguito egli definì “matto e disperatissimo”-, nella nutrita biblioteca paterna, all’interno del loro grande palazzo di famiglia; esso divenne infatti il suo rifugio, l’unico mezzo che aveva a disposizione per esprimere le sue potenzialità, sebbene in maniera necessariamente solitaria, in quanto giovane rampollo di famiglia nobiliare e quindi fin dall’inizio destinato a studiare privatamente. Arrivò così ad appassionarsi alle lingue e culture antiche, traducendo dal Latino, dal Greco e dall’Ebraico, e sviluppando una teoria sul Mito, come espressione delle antiche culture, appunto, le quali, vivendo in modo più semplice e a contatto con la natura, avevano potuto coltivare i loro sogni e la loro immaginazione e, in sostanza, una certa felicità.
Negli anni 1815-1816, cioè a diciassette – diciott’anni, dall’amore per il sapere passò a quello per la bellezza, nell’arte e nella letteratura, e tentò d’inserirsi nel dibattito culturale dell’epoca, incentrato sul dissidio tra classicisti e romantici: la sua posizione alla fine non rientrò in alcuno dei due “schieramenti”, poiché lui li superò entrambi, giungendo a una concezione della vita che si può forse dire “materialistica” e atea, e che lo portò a produrre scritti filosofici come le “Operette Morali”, ma anche lirici e struggenti come i “Canti”, in particolare gli “Idilli”, ritornando con questi alla poesia, che in seguito non abbandonò più. Nonostante i suoi gravi disturbi fisici, egli si rivelò instancabile nelle sue “esplorazioni culturali” e nei suoi viaggi, lontani dal suo “natìo borgo selvaggio”, tra Milano, Bologna, Firenze e Pisa, tutt’altro che un povero giovane depresso ripiegato su sé stesso…
Era profondamente convinto che la razionalità, la conoscenza e il progresso scientifico, propri della civiltà moderna, avessero necessariamente operato il distacco dell’essere umano dalla natura, causandone l’infelicità. In seguito il suo pensiero si spinse oltre, il suo pessimismo divenne “cosmico”, giungendo alla teoria che la Natura, in fondo, sarebbe una “matrigna” rispetto a tutti gli esseri viventi -in particolare per il genere umano, che parrebbe averne maggiore consapevolezza-, giacché si nasce, si vive, si soffre e, infine, si muore, nella sua totale “indifferenza” nei nostri confronti: tale sarebbe la nostra misera condizione; ma è proprio per questo motivo che gli esseri umani, invece che ostacolarsi, odiarsi e arrivare persino ad uccidersi l’un l’altro, specie con le guerre, dovrebbero unirsi in una lega fraterna per cercare di combattere le enormi avversità che la natura può riservare, nel suo moto incessante e indifferente. Leopardi espresse chiaramente questo suo pensiero ne “La Ginestra”, uno dei suoi ultimi “Canti” -scritto durante il suo soggiorno a Napoli, trascorso insieme all’amico Antonio Ranieri-: lungo al punto da poter essere considerato un “poemetto filosofico”, esso presenta anche una forte critica, sotto forma di amaro sarcasmo, alla cieca fiducia di molta gente della sua epoca nel cosiddetto “Progresso” della civiltà umana. Così la Ginestra, quest’umile piantina capace di crescere sulle pendici ricoperte di lava ormai spenta del vulcano Vesuvio, diventa un simbolo dell’eroica resistenza contro l’annientamento più totale. E, in tutto ciò, con la sua tensione verso “il vago e l’indefinito”, la poesia diviene il principale strumento di ricerca del piacere e della felicità, e quindi di quell’ “assoluto” e quell’“infinito” ai quali anela la nostra anima tormentata, mitigando almeno in parte la nostra sofferta inquietudine…
Vittoria Montemezzo
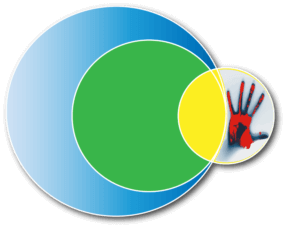











Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!