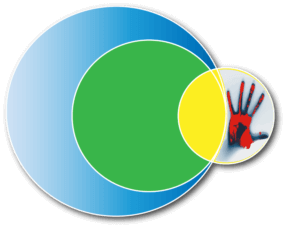Inizialmente, la storia di questa città, ancora senza nome, così come quella del
territorio circostante, fu legata alla storia della colonia romana di Luni: questa prese
avvio con la fondazione della città di Luna, alla foce del fiume Magra, nel 177 a.C., da
parte dei Romani, appunto; ma il suo porto era già utilizzato da tempo per l’attracco
di navi mercantili greche ed etrusche, e da ciò si comprende la sua importanza
“strategica”, che i Romani non si lasciarono sfuggire, nel momento in cui riuscirono a
prendere il sopravvento sulla popolazione di Liguri che abitava già da prima in quel
territorio, e che si era dimostrata assai difficile da conquistare.
Essi le diedero
dunque questo nome, consacrandola alla dea dell’astro notturno, probabilmente a
causa della forma di falce del suo porto, e corrispondente alla dea Selene, alla quale
già i Greci l’avevano consacrata; per i Romani, inoltre, questa divinità spesso non era
altro che un aspetto di Artemide-Diana, la dea della notte, della caccia e dei luoghi
selvaggi, probabilmente anche in riferimento alle ampie zone paludose che
circondavano quei luoghi, e che loro si apprestarono a bonificare.
In seguito alla caduta dell’Impero Romano nel 5° secolo, la regione venne devastata
dai barbari Eruli e Goti, ma con la successiva guerra gotica l’Impero Bizantino la
riconquistò, ed essa divenne parte dell’Esarcato d’Italia, come Provincia bizantina di
Liguria. Arrivarono poi i Longobardi, con il re Rotari, che la staccarono dal ducato di
Liguria annettendola a quello di Tuscia, e che contrastarono l’autorità dei vescovi di
Luni; i quali però la riacquisirono e si rinforzarono divenendo vescovi-conti sotto il
successivo dominio franco di Carlo Magno.
Dall’860 seguirono incursioni di Vichinghi e Saraceni, che portarono la zona al
decadimento. Così, nel 9°secolo, il centro più importante del Golfo era diventato
Vesigna, sul colle Marinasco; da qui però parte della popolazione cominciò a
migrare, contribuendo alla formazione di un primo borgo sul “Poggio” della Spezia,
che si sviluppò tra il 10° e l’11° secolo. La regione era entrata ora a far parte del
“Regno d’Italia” -come la maggior parte del Nord Italia- e nello specifico della marca
Obertenga.
Dall’inizio del 12° secolo, la Repubblica di Genova cominciò ad accrescere la sua
influenza sul Levante Ligure, La Spezia compresa: il cui nome viene citato, una delle
prime volte, in alcuni documenti del 1160, nei quali tali “Bonus Johannes e Baldus de
Specia” stabiliscono tra loro accordi commerciali.
Nel 13° secolo, ormai nell’orbita della Compagna Genovese, il borgo prese a
svilupparsi, grazie al commercio e all’industria del sale, mantenendosi tuttavia per
20 anni svincolato dal dominio di Genova; ciò permise a Niccolò Fieschi, un
esponente di parte guelfa, di creare un’effimera Signoria guelfa, tra il 1256 e il 1273,
che però terminò con la conquista del politico e ammiraglio Oberto Doria.
Tra il 13° e il 14° secolo, La Spezia proseguì il suo sviluppo, giungendo a diventare il
centro principale del Golfo, e nel 1343 il Doge Simon Boccanegra ne istituì la
Podesteria, che nel 1371 si unì a quella della vicina Carpena, per poi sopravanzarla;
inoltre si iniziò a costruire una solida cinta muraria a sua difesa.
Il 15° secolo segnò ulteriormente la sua crescita, specialmente nell’attività
commerciale, accanto a pesca e agricoltura; e finalmente, nel 1407, anch’essa poté
dotarsi di propri Statuti, cioè le leggi e le disposizioni che regolamentano la vita di
una comunità: una conquista davvero importante per la città, ciò che in un certo
senso la rendeva ufficialmente tale, riconosciuta dalla stessa Repubblica Genovese:
nacque così la “Comunità Spedia”.
Nel 1472, Genova era entrata a far parte del dominio milanese degli Sforza, e
conseguentemente anche La Spezia, dove quindi per volere del Duca di Milano
Galeazzo Maria Sforza prese avvio la costruzione di un arsenale.
Nel 1571, durante il periodo imperiale spagnolo di Carlo 5°, ottanta galee spagnole
presero posto nel suo Golfo, prima di unirsi alla flotta della “Lega Santa” contro i
Turchi Ottomani nella battaglia di Lepanto.
Nel 1606, tutte le fortificazioni della Spezia e del Golfo vennero revisionate e
consolidate.
Nel 1654, mercanti ebrei e stranieri furono invitati a stabilirsi nella città,
vivacizzandone così gli scambi commerciali, e allo stesso scopo venne istituita la
fiera annuale di S. Giuseppe, il suo patrono.
Nel 1797, con la Rivoluzione Francese, La Spezia si affrancò da Genova e divenne “Il
Dipartimento di Venere”, entrando a far parte della Repubblica Ligure dell’Impero
Francese; nel 1808, sotto Napoleone, diventò ufficialmente un porto militare, e si
intrapresero importanti opere pubbliche, tra le quali una rete stradale più ampia e
funzionale.
Con la Restaurazione, nel 1815 divenne parte del Regno di Sardegna, e nel 1823
capoluogo della Provincia di Levante, continuando il suo accrescimento. Le sponde
del Golfo, con la loro bellezza, unita alla mitezza del clima, cominciarono ad attrarre
colti viaggiatori ed artisti di ogni tipo, pittori, musicisti, poeti…anticipando così la sua
vocazione turistica.
Tra il 1862 e il 1869 venne costruito un Arsenale Militare Marittimo, come
precedentemente deciso dal governo piemontese con “regio decreto” (nel 1849), e
il Presidente del Consiglio dei Ministri di allora, nonché Ministro della Marina, il
Conte di Cavour, si occupò di trovare i fondi.
Nel 1891 cominciarono i lavori di costruzione del porto mercantile.
Nel 1923 diventò capoluogo di provincia, e nel ’29 sede diocesana.
Ed eccoci giunti alla Seconda Guerra Mondiale: nel 1944, La Spezia venne
pesantemente bombardata, e gran parte dei suoi edifici furono distrutti; ma sarà in
seguito tra le città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione dal
Nazifascismo.
Nel 1946, dal suo porto salpò la nave “Exodus”, che portava 4500 Ebrei sopravvissuti
allo sterminio verso la Palestina, affinché potessero trovare accoglienza presso la
comunità ebraica residente in quella terra.
E oggi è annoverata tra le città italiane promotrici della “Rete delle Città
Strategiche”.
In sostanza, questo è stato tutto il percorso che ha portato La Spezia a divenire sé
stessa.
Vittoria Montemezzo