LE CASE DI TERRA DI VILLA FICANA
Nella periferia a nord della città di Macerata, nelle Marche, presso il colle Santa Croce, esiste un borgo di case fatte di terra e paglia; una prima testimonianza “ufficiale” della sua esistenza si trova in una mappa catastale del 1268, in cui in questo luogo viene indicato un gruppo di abitazioni con il toponimo di “La Ficana”. Questo primo insediamento, tuttavia, fu in seguito abbandonato; fino al suo ripopolamento nel 19°secolo, quando assunse l’aspetto odierno: ciò è attestato da un mattone in terra cruda e paglia ritrovato alla sua entrata nel 2006, durante lavori di restauro, inserito nel muro di un’abitazione costituita dallo stesso materiale, e riportante la data del 1862. In questo periodo, dunque, il borgo s’ingrandì, parallelamente all’aumento degli abitanti della zona, per lo più piccoli proprietari coltivatori con poca terra o poveri braccianti senza terra, che avevano bisogno di un lavoro e non potevano permettersi altro che l’affitto di quelle case: i cosiddetti “casonanti/casanolanti”.
Per questo motivo, tali case, dette “atterrati”, dal secondo dopoguerra vennero poi associate ad un concetto di povertà, e a volte “manomesse”, senza rispetto per le loro caratteristiche edilizie, nonché abbandonate. Inoltre, negli anni ‘80 e ’90 si assistette ad un periodo di costruzione “selvaggia” di strutture sproporzionate e invasive intorno a questo territorio, senza riservare zona alcuna a servizi per la comunità, come parcheggi e aree verdi. Furono necessari i primi anni 2000 per vedere finalmente crescere l’interesse per questo borgo e le sue antiche tecniche costruttive, tanto che nel 2003 esso venne posto sotto tutela giuridica in qualità di sito riconosciuto d’interesse storico-monumentale, e quindi da dover preservare: ora il suo nome era diventato “Quartiere di Villa Ficana-Case di Terra” di Macerata; così, negli anni 2005-2006 vi furono avviati i lavori di restauro conservativo, grazie a fondi Regionali ed Europei, acquisiti dal comune stipulando accordi con i proprietari delle Case, che prevedevano la concessione, da parte di questi ultimi, delle loro proprietà al comune stesso per 10 anni, al termine dei quali queste sarebbero ritornate loro. Con queste opere di restauro si poté quindi preservare la storia e la bellezza architettonica e paesaggistica del quartiere. Nacque così, nel 2016, l’“Ecomuseo”, parte ufficiale della rete di Macerata Musei, costituito da nove di questi edifici, tra i quali cinque destinati specificamente alle attività ad esso collegate: la ricostruzione degli ambienti in stile novecentesco e laboratori didattici, in cui vengono valorizzate nonché promosse e insegnate le tecniche costruttive tradizionali con paglia e terra cruda, per loro natura efficaci, sostenibili ed “eco-compatibili”; ciò ha consentito di mantenere viva e attuale questa cultura popolare, trasmettendo i suoi valori più positivi alla società odierna.
Gli ambienti ricostruiti per la visita guidata sono tre:
-LA CUCINA: arredata come all’epoca, il suo “cuore” è costituito dal camino, che la caratterizzava come l’unica stanza riscaldata della casa, punto di ritrovo, quindi, di tutta la famiglia; non c’era però l’acqua corrente, rifornita tuttavia dalla fonte pubblica del Borgo. Gli antichi utensili presenti ci “raccontano” con il loro aspetto la povertà e l’essenzialità del modo di cucinare di allora;
-LA CAMERA DA LETTO: essa è occupata da un unico letto, posto in modo tale da lasciare spazio ai pagliericci di foglie di mais, che costituivano un tempo i giacigli destinati ad ospitare gli altri membri della famiglia, solitamente assai numerosa. Accanto alla finestra è presente il vaso che veniva utilizzato per le “necessità fisiologiche” notturne di tutti loro…;
-LA STANZA CON IL MURALES: questa, infine, riporta sulla parete una riproduzione dell’immagine raffigurata su di una tela “ex-voto”, conservata nella piccola basilica di Santa Maria della Misericordia, nel centro storico di Macerata: un incendio scoppiato nel Borgo nel 1891 -a causa della “liscivia”, una soluzione detergente composta da cenere di legna, una volta utilizzata per sbiancare il bucato-, che si spense allorché i suoi abitanti cominciarono a pregare la Madonna della Misericordia, la quale fece scendere dal cielo una pioggia miracolosa… Tali incendi avvenivano di frequente nel Borgo, a testimonianza, ancora una volta, delle dure condizioni di vita di coloro che vi abitavano un tempo.
Vittoria Montemezzo
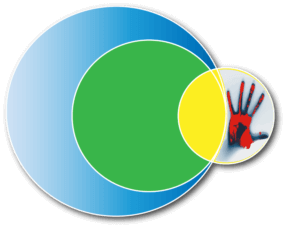












Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!